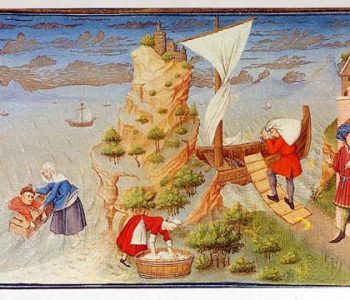Amedeo Maiuri
Passeggiate in Magna Grecia
Introduzione a cura di Franco Vitelli
I testi proposti – con più pertinente corrispondenza al progetto Polysemi – sono stralciati dal volume di Amedeo Maiuri, Passeggiate in Magna Grecia (Napoli, L’arte tipografica, 1963, pp. 196-208). Si tratta di un’opera postuma, allestita con materiale disperso, per rendere omaggio all’insigne archeologo; vi è apposta una commossa Presentazione di Attilio Stazio in cui viene data peraltro voce ai meriti della vedova, degli amici, dei colleghi e discepoli. Si apprende altresì della natura incompleta del progetto; l’autore è stato impedito di portarlo a termine, sicché la raccolta presenta “un qualche squilibrio”. Tuttavia, anche nella presente strutturazione, il libro offre pregi di indubbio interesse compreso il prezioso corredo delle illustrazioni. Forse, la non facile reperibilità spiega l’assenza, da quel che a me risulta, dalle bibliografie correnti riguardanti la letteratura odeporica nelle zone oggetto d’indagine. Attilio Stazio ci dice che era nei progetti e desideri di Maiuri un libro sulla Magna Grecia, ma non che sia stato lo stesso autore a dare il titolo; comunque sia, è un dato che il nostro abbia in vita pubblicato le Passeggiate campane con progressivi riassetti (1938, 1940, 1950, 1958). C’è un’indubbia corrispondenza tra le due opere a cominciare dal significato da attribuire al termine “passeggiate” che torna in entrambe. “Chi scrive ha continuato la buona e salutare abitudine di peragrare le vie della Campania e non ha saputo rinunciare a riprendere il suo amoroso colloquio con le cose vecchie e nuove di questa terra” (Premessa a edizione del 1950, p. VII); “Dopo aver peragrato per i campi seguendo il rilevato ancora riconoscibile […] convenimmo che se un’esplorazione dev’esser fatta non dovesse tralasciarsi Rudiae” (A traverso il Salento). La passeggiata comporta dunque la perlustrazione attraverso i campi, rimanendo con ciò fedele all’etimo della parola; non vi è escluso tuttavia un senso di devoto pellegrinaggio nei luoghi in cui più splendono i segni delle antiche civiltà. Siamo su un piano diverso rispetto al lieto girovagare del flâneur che investe la realtà cittadina e le divagazioni della mente.
Il titolo Passeggiate in Magna Grecia (e l’altro, Passeggiate campane) con ogni probabilità riprende un lontano archetipo del 1829, Passeggiate romane di Stendhal, e si pone come l’antecedente naturale delle Passeggiate in Magna Grecia (1985) di Carlo Belli, molto vicino a Maiuri e curatore di una imponente antologia dei suoi scritti. Non è un caso, quindi, che proprio nella Prefazione ai suoi due volumi Belli fornisca la giusta chiave di lettura delle pagine qui riportate, indicando il proprio dell’agire di Maiuri nel fatto che è stato “tra i primi in Italia a sgelare la scienza, a indurre una linfa umana nella epigrafia, a servirsi della scienza come di un mezzo. Il suo impegno era principalmente umano, e questo calore egli ha infuso in ogni suo scavo, in ogni suo libro e discorso. La scienza è tutto, e ben le si addice la severità e il rigore ma essa è nulla, se a un certo punto non riesce a diventare palpito”.[1] Si pensi che Belli è stato l’ideatore nel 1960 del Convegno di studio sulla Magna Grecia, poi diventato consolidata tradizione, ed era il sostenitore dell’idea di “mettere di moda la Magna Grecia”;[2] di fronte alla quale Maiuri sorrideva, in cuor suo condividendone il proposito. Lo si evince anche da un pezzo del novembre del 1961 (Convegno a Taranto) nel quale spiega le ragioni del perché Taranto sia la sede ideale e più rappresentativa, aggiungendovi un di più di penetrazione critica circa il rapporto tra passato e presente, quando introduce il tema di una necessaria e problematica convivenza: “al momento stesso in cui Taranto si accinge ad essere il maggiore centro metallurgico del Mezzogiorno, parta da Taranto stessa un richiamo all’arte e civiltà della Magna Grecia, in modo da associare a quella rinascita industriale il calore e la luce della civiltà antica”.[3] Un eguale collegamento, spostato tuttavia sul versante dello sviluppo agricolo, troviamo a proposito dell’inaugurazione dell’Antiquarium di Metaponto, sempre nel 1961. Maiuri, nel ringraziare il Ministro, sottolineava il fatto di aver voluto “associare opere destinate alla rinascita agraria di questa terra ad una, che di questo suolo esprime l’antica civiltà e ricchezza”. Le due cose (“il ritorno alla terra e il ritorno al culto delle nostre memorie”) non potevano che procedere congiunte; la creazione dell’Antiquarium veniva a colmare la frattura esistente a seguito dei benefici effetti della bonifica e della riforma agraria (“Donava la terra il pane agli uomini, ma gli uomini erano dimentichi che su quelle terre altri uomini avevano edificato e creato opere memorabili”).[4]
L’auspicio di Maiuri di conciliare industrializzazione e natura-cultura si sarebbe rivelato presto fallace e, anzi, progressivamente rivolto verso il peggio. A tal proposito, si veda il complesso e articolato pezzo su Taranto di Carlo Belli il quale, anche a costo di apparire “stonato” nel mentre suscita a nuova vita antichi miti, insiste – in apertura, corso del testo e chiusura – sugli effetti nefasti del centro siderurgico “caldaia bollente di fervori umani, inferno di opere ciclopiche, e di incontrollate ambizioni politiche” che “deturpa e condiziona la città”, “erutta vapori infami, fiamme infernali, creando una nube rossastra su tutta la città”. La conclusione non può che essere di straziante nostalgia quasi di sapore manzoniano: “Addio, notti tarantine, scintillanti di ben altre luci!”. E anche sul versante agricoltura Belli smitizza, perché “le bonifiche agrarie scatenano buldozer su terre gravide di testimonianze storiche e la speculazione privata, favorita da corruzione politica, sconvolge aree archeologiche trasformate cinicamente in aree fabbricabili”.[5]
La storia dei luoghi visitati e il “mestiere di archeologo” per una vita esercitato da Maiuri condizionano inevitabilmente la natura e il contenuto di queste sue prose di viaggio. Una volta Vincenzo Consolo,[6] presentando Il viaggiatore amoroso di Dominique Fernandez, a proposito dei viaggiatori in Italia parlò di una “linea goethiana” che in modo orizzontale “vede, descrive, racconta” la ricchezza della natura e della storia; e poi dell’altra, la “linea stendhaliana”, che in forma verticale ritrova nei posti una “dimora dell’anima”, una patria in cui ci si riconosce. Si direbbe che Maiuri ha felicemente coniugato l’una e l’altra tendenza, mettendo in opera un suo originale modello. Il nuovo genere è sostenuto da un uso narrativo del mito che rende accattivante e coinvolgente la lettura, a cominciare dalle origini leggendarie di Taranto che sarebbe stata fondata sì dagli spartani, ma non di prima scelta in quanto nati da donne che avevano sostituito i vigorosi mariti impegnati in guerra. E quale suggestiva atmosfera crea l’eroe Falanto che cavalca “il dorso guizzante di un delfino” tra i dolci flutti dello Ionio! Ciò non inficia il sedimento storico e scientifico da cui Maiuri parte e lascia filtrare talvolta una cautela ironica e illuministica, come quando si riferisce alla consultazione dell’oracolo o all’offerta dei pomodori alla divinità per la ripresa degli scavi. È piuttosto quella definizione di “poeta dell’archeologia”[7] che occorre valorizzare, cercando di spiegarne i modi anche per questi scritti. Maiuri conosceva l’arte dello scrivere bene e la sua prosa è permeata da una raffinatezza letteraria che non disdegna la forma eletta (“polle d’acqua spiccianti”, “regolo”, “meati”, “avelli”, “salso del mare”, “noria”, “ciuco”, “villici”), ma che mai rifugge dalla chiarezza, connotato indispensabile anche al fine divulgativo. Rileva, in tal senso, l’intensa collaborazione ai giornali e specie al “Corriere della Sera”, dove sono apparsi molti elzeviri, alcuni dei quali rifluiti nelle nostre passeggiate magno-greche.
Le virtù creative di Maiuri alimentano il suo “attivismo podistico” di “archeologo errante” dotato di un fiuto incredibile nell’orientare gli scavi, ma pure trovano riscontri nelle puntuali descrizioni del paesaggio avvolto da suggestivo fascino poetico: “Dalla Torre si domina gran tratto della costa, tutta a seni e basse lingue di terra, ove lo Ionio prende il suo più tenero colore di stoffa setosa iridata di opalescenze perlacee, mentre la terra fulva par riflettere anch’essa, nel verde smeraldino dei pinastri, quel magico colore delle acque”. Ovvero: “Valichiamo il carso tarantino, nudo e vampante nella calura d’agosto, ed ecco sul pianoro delle Murge la terra improvvisamente lievitare e gonfiarsi di turgide mammelle: attraversiamo la zona dei trulli di Martina e Locorotondo, che, pur senza addensarsi nell’abitato di Alberobello, vi danno, sparsi o appaiati su quella terra di color sanguigno e densa e cupa di vigneti, con i loro pinnacoli lisci o squammati, grezzi o imbiancati come cupole di marabutti, la visione di un paese fiabesco”. La bella scrittura non altera la realtà, piuttosto la rende invitante come per un itinerario cui il lettore non potrà sottrarsi.
Maiuri ebbe in sommo grado “la facoltà di riproporre in dimensioni attuali la realtà del passato. Con raffronti e similitudini, con ‘trovate’ e accostamenti, a volte audaci, a volte scherzosi, sempre vitalissimi e centrati”.[8] È sempre Carlo Belli a darci questa indicazione di straordinaria acutezza e suggestione, della quale troviamo conferma anche qui nel nostro specifico. Anzi, si potrebbe dire che queste parti sono le più vive e felici per il grado di coinvolgimento che comportano.
Un problema di fronte al quale il lettore si trova è il contrasto tra la realtà tarantina del passato descritta in termini di splendido virgiliano idillio, al punto che, secondo l’arcivescovo Capecelatro, in quel contesto Dio avrebbe perdonato ogni peccato, e quella del 1950 in cui i monumenti appaiono distrutti dalla costruzione del castello aragonese. La contraddizione viene sciolta spostando il centro d’interesse sul Museo che è come la sintesi vivente tra passato e presente.
Si diceva della peculiare capacità di “attualizzare” o, meglio, di rendere partecipate per i moderni le cose degli antichi. Valgano alcuni esempi. Alla costruzione di “Taranto vecchia” forte incremento diede il materiale proveniente da reperti archeologici, sicché capita al Maiuri di osservare una colonna dorica “con il suo intatto capitello adattato a balcone e ombreggiato dal fusto serpentino di una vite che vi si distende bellamente al di sopra”. Non c’è la reazione stizzita e violenta, come pure sarebbe giusto, per l’uso improprio di così alti beni architettonici; al contrario, Maiuri sembra accedere all’idea che “quel dorico balcone inghirlandato di pampini” ci coinvolga in una operazione di riuso che genera una nuova forma di bellezza. Insomma, per lui è importante non creare distanza e abbandono. Si veda anche quello che dice a proposito del menhir di Muro Leccese depositato in un angiporto: “l’avessero collocato in una piazza, sarebbe stata la più singolare segnalazione stradale dei nostri tempi; una pietra fitta dell’età preistorica in funzione di regolatore del traffico automobilistico”. Certo, filtra ironia nell’immaginare quell’insolita rotatoria; ma credo prevalga il bisogno interiore di vicinanza. Alla stessa maniera, l’esposizione della raffinata arte tarantina, curata con modernità d’indirizzo dal Soprintendente Ciro Drago nelle sale del Museo, non spinge a una chiusura nel passato splendido. Statuette e monili parlano ancora in maniera superba, al punto che gli ambienti parigini potrebbero certo lì trovare ispirazione per le eleganti sfilate di moda e le sapienze degli orafi.
La parte riguardante “i Messapi più civili ed evoluti” ha quasi un’autonomia narrativa; tornerebbe suggestivo dare come titolo del racconto I pomodori di Egnazia. Colpisce la sua natura articolata in cui confluiscono diverse componenti: la descrizione paesaggistica, il riferimento al sito archeologico, l’abbandono degli scavi e la destinazione a coltura agricola dei luoghi, l’intatta natura salmastra delle acque per le Ninfe irate (a 1987 anni di distanza dal viaggio di Orazio da Roma a Brindisi con Mecenate e Virgilio) che favorisce una particolare varietà di pomodoro. Gustare en plein air “una saporosa e salutare insalata” è privilegio che tocca alla brigata di Maiuri, ma non all’antica, considerata la tardiva ottocentesca diffusione della pianta nell’Alto Salento. I pomodori di Egnazia potrebbe anche essere la denominazione di un particolare itinerario turistico, culturale ed economico che si parte dall’archeologia e approda all’attuale fiorente coltivazione dei pomodori regina. Un modo, questo, per rendere omaggio ad Amedeo Maiuri e all’impiger Apulus, protagonista della letteratura e delle profonde trasformazioni socio-economiche.
Amedeo Maiuri
DAL GARGANO AL SALENTO
Fra greci e messapi
Taranto, ottobre 195O
Gli storici debbono ancora spiegare come da Sparta, dallo stato più militare della Grecia, sorgesse Taranto, la città più mercantile e artistica della Magna Grecia, pervenuta, dopo cruente guerre con i Messapi, a tale desuetudine dalla milizia, da mendicare contro Lucani, Bruzi e Romani l’aiuto, tutt’altro che disinteressato, dei più famosi e pericolosi capitani di ventura. Ma, a stare alla leggenda, Spartani proprio di buona razza non furono: erano i figli nati dalle donne spartane, durante le troppo lunghe assenze dei mariti alle guerre messeniche, ai quali si finì per dare un nome di pietosa o maliziosa indulgenza: i «Partheni», i «Vergini». Era comunque un nome che li condannava ad un’inferiorità civile e politica, e, un bel giorno, i Partheni, interrogato l’oracolo, abbandonano Sparta e sbarcano nella più bella rada d’Italia, combattono quel tanto che occorre per snidare qualche villaggio di indigeni dalla barbara favella, e occupano la penisoletta che sbarrava l’immenso bacino del Mare Piccolo. Dei coloni che fossero venuti dalle città più marinare di Grecia, non avrebbero saputo scegliere un sito più marino di quello.
Fu certo l’oracolo d’Apollo a indirizzare i diseredati di Sparta verso un destino così diverso da quello della loro patria: invece delle magre acque dell’Eurota, il più gran porto d’Italia e una costa frastagliata e lambita dal più dolce flutto dello Ionio, sicché l’eroe Falanto poteva percorrerlo cavalcando il dorso guizzante d’un delfino; e invece del nevoso Taigeto, una terra coperta di bassa boscaglia, che saliva dolcemente di terrazzo in terrazzo fino a un pianoro, da cui discendeva pianamente verso un altro più chiuso e increspato mare. E, in luogo delle greggi dei pastori d’Arcadia, trovarono i caci, le lane e gli agnelli dei pastori di Lucania, che venivano, da una regione tutta chiusa da monti selvosi, a svernare al mare, tra le ériche, i mentastri, le cerase marine e le polle d’acqua spiccianti segretamente dalla crosta rocciosa del piano; e scoprirono, dono più prezioso di Poseidon, nel Mare Piccolo una gran pescaia di pesci e molluschi, come un’immensa rete di cui essi, stando su quella penisoletta a specchio dei due mari, tenessero in mano il governo. Così beneficiati, i «Vergini» di Sparta diventarono in Italia industriosi, agili e scaltri, maestri delle più fini arti della metallurgia e dell’oreficeria, della ceramica e della plastica, e così politicamente maturi che, nel momento più critico dell’ellenismo insidiato dal tiranno di Siracusa, quegli che avrebbe potuto essere il loro tyrannos, fu il pitagorico, matematico, ingegnere e legislatore Archita tarantino, tanto saggio e temperato nell’arte del governo, da creare una federazione politica commerciale e monetale fra le maggiori città dello Ionio, presieduta da Taranto; più felice in questo del grande Pitagora, che non era riuscito ad evitare la lotta fratricida fra Sibari e Crotone. Fu l’ultima grande luce della Taranto greca: poi, nell’ansietà della difesa contro gli Italici e contro Roma, mendicherà l’aiuto di strateghi e di re stranieri e di truppe bisognose di soldo e di cibo. Ma, se nelle mani di Alessandro il Molosso e di Pirro, potrà inalberare ancora il vessillo dell’indipendenza contro i Lucani e contro Roma, nelle mani di Annibale non avrà da scegliere che tra l’egemonia romana e quella cartaginese, e la sua sorte sarà segnata.
Taranto romana, senza mura, senza flotta, senza la sua bella zecca di monete fiammanti d’oro e d’argento, diventerà una città di delizie, di arti raffinate, un’Arcadia pastorale e marittima: molle Tarentum. Ville e giardini sorgeranno intorno al Mare Piccolo; Virgilio vi collocherà il suo più perfetto quadro di vita idilliaca: l’orto e il verziere del vecchio Coricio presso la polla del fiumicello Galéso; i Lucani torneranno a stabulare nella pianura e le pecore immerse nelle gelide acque del Taras, forniranno la più bella e bianca lana dell’impero; e i Tarantini, invece di tingere le vesti delle loro donne, tingeranno di porpora le toghe romane. E l’ultima voce della Taranto idillica e pastorale ci verrà, alla fine del settecento, da un prelato che, pur tra rivoluzione e reazione, non ebbe tutti i suoi sonni tranquilli, dall’arcivescovo Capecelatro che, conciliando Bibbia e umanesimo, fece incidere sulla porta della sua villa il motto: «Si Adam hic peccavisset, Deus ignovisset: Se Adamo avesse qui peccato, Dio l’avrebbe perdonato».
Ma Taranto antica, fra guerre, massacri e delizie, ha troppo vissuto per conservare una traccia visibile dei suoi monumenti: a distruggerli provvide esaurientemente il Castello aragonese con i suoi possenti bastioni, e a giovarsene provvidero le case della vecchia città, che han fatto una compatta muraglia di alveare umano fra i due mari. Sicché par quasi un miracolo vedere, nel cortiletto d’una canonica, spuntare, chissà da quali meati sotterranei, il sommoscapo d’una colonna dorica, con il suo intatto capitello adattato a balcone e ombreggiato dal fusto serpentino d’una vite che vi si distende bellamente al di sopra: e confesso che, a vedere quel dorico balcone inghirlandato di pampini, ho pensato più al motto dell’arcivescovo umanista, che a Simone stilita.
In compenso, la vita di Taranto antica si rispecchia interamente nel suo bel Museo, che deve la sua origine al nuovo destino navale della moderna città (70 anni fa non c’erano che collezionisti e antiquari). Si taglia lo Scoglio del Tonno e vien fuori una stazione preistorica di indigeni, accampati tra le ripe dei due mari, che, tra violenti contrasti di nordisti e sudisti, vengono, non si sa perché, battezzati per terramaricoli discesi dalla valle padana; si scavano bacini e fondali per l’Arsenale e vien fuori la necropoli greca del VI e V secolo a. C.; si amplia e si distende il Borgo nuovo a ventaglio con una pianta che potrebbe essere ippodaméa, e vengono alla luce colonne, capitelli, rilievi, camere sepolcrali e preziose oreficerie della città ellenistica. Raccoglitori instancabili e pazienti, fra le insidie d’un mercato antiquario che riesce purtroppo a fare piccoli e grandi colpi, il tarantino Luigi Viola, il romagnolo Quintino Quagliati e oggi, alle prese con il definitivo riassetto delle collezioni in un Museo ampliato e ammodernato, uno studioso silenzioso e fattivo, il palermitano Ciro Drago.
A Ciro Drago debbo la prima esatta conoscenza con i Messapi Tarentini, quelli che contrastarono ai Greci il possesso del Mare Piccolo e, vinti ma non domi, continuarono a vivere a loro modo, a parlare la propria lingua e a chiamare le loro città con i vecchi nomi japigi. Li ha trovati a Torre Castelluccia, a una ventina di chilometri a oriente di Taranto, una bella torre tozza e panciuta che, con altre che le si allineano accanto, difendeva la costa dai barbareschi: poco discosti sono la Torre Satùro e il capo Saturio che conservano, in quel prezioso toponimo, il ricordo della leggenda di Saturia, figlia di Minosse, sbarcata da Creta con l’eroe Japige ; e, leggenda a parte, sta di fatto che, tanto allo Scoglio del Tonno quanto a Castelluccia, è un formicolìo di ceramiche del tardo miceneo cretese e rodio, indizio inconfutabile di commerci vivi e continui con Creta e l’Egeo.
Dalla Torre si domina gran tratto della costa, tutta a seni e basse lingue di terra, ove lo Ionio prende il suo più tenero colore di stoffa setosa iridata di opalescenze perlacee, mentre la terra fulva par riflettere anch’essa, nel verde smeraldino dei pinastri, quel magico colore delle acque. Al di sotto della Torre, si stende la spianata del promontorio, calvo pelato, riarso, la classica patèla delle acropoli di Creta e di Rodi, con un porticciuolo a oriente e una dolina conica a ponente, che par proprio fatta per il chiuso d’una mandra. Le trincee che vi si fecero durante la guerra, valsero a scoprire i primi cocci e a rivelare, con tre successivi strati di giacimento, l’importanza della stazione: lo scavo sistematico, cominciato due anni or sono, dura e durerà ancora. Ciro Drago sa, da scavatore provetto, che la fretta è nemica di chiarezza, e dopo lo Scoglio del Tonno, che ha tenuto in subbuglio per molti anni la preistoria italiana, non c’è che imporsi la disciplina più severa dello scavo stratigrafico. Così, dopo il bivacco di guerra, s’è creato alla Torre Barbaresca un bivacco archeologico. È una milizia anche questa: si fanno le provviste a Pulsano, un paesino che sembra trapiantato con le sue basse tinte di bianco e d’azzurro da un’isola dell’Egeo; si mangia il pesce pescato negli anfratti del Capo Saturio, lo stesso pesce che il regolo messapico deve aver ammannito quando ospitava alla sua mensa mercanti rodii e cretesi; e, a guardia della Torre, c’è un reduce d’Africa, interprete di lingua Galla e Suheli, che spera forse d’interpretare il muto linguaggio dei preistorici di Castelluccia.
Sono salito, scavalcando le valanghe degli scarichi, sulla spianata. Pare da prima di trovarsi entro il letto d’un torrente dopo la piena, quando le acque ristagnano e sulla melma rassodata affiora il ciottolame trascinato a valle, lungo il filo della corrente. Ma a poco a poco l’occhio si abitua: riconosce il muro delle capanne, il battuto rossiccio d’un focolare, un cumulo di ceneri impastate con il cocciame d’una pentola, il cavo lasciato da un grosso ziro d’acqua, il rilevato d’una massicciata stradale, il muro di cinta che serrava con una robusta cortina bastionata l’abitato. È bastato sollevare 40-50 centimetri di terra su tutta la spianata, per scoprire l’ultimo e più recente periodo della vita del villaggio. Sono gli indigeni che hanno assistito alla venuta dei Greci di Sparta e che vantavano anch’essi di discendere dalla stirpe di Minosse; e sono forse questi stessi Japigi-Messapi che, fino a ieri, si facevano venire dall’Illirico e che oggi si è più propensi a ricollegare ai Siculi mediterranei, la cui penetrazione nell’Italia centro-meridionale appare più vasta e profonda: così anche la preistoria viene a dare il suo appoggio a quei meridionalisti, che fanno risalire la civiltà dal sud al nord della penisola e che comunque rivendicano al Mezzogiorno una sua propria omogenea e coerente civiltà.
Dopo aver fatto la conoscenza con i Messapi del villaggio ionico di Castelluccia, siamo andati a trovare i Messapi più civili ed evoluti nell’antica città di Egnazia, a mezza costa fra Brindisi e Bari: d’un balzo dallo Ionio all’Adriatico. L’han chiamata non senza ragione la Pompei delle Puglie, perché è la sola città antica che sia morta senza rinascita: Gnathia messapica, rivisse greca e romana, poi morì esausta, rimpiazzata un po’ a nord da Monopoli, conservando a stento il suo corrotto nome in un torrione solitario: la «Torre d’Anazzo».
Valichiamo il carso tarantino, nudo e vampante nella calura d’agosto, ed ecco sul pianoro delle Murge la terra improvvisamente lievitare e gonfiarsi di turgide mammelle: attraversiamo la zona dei trulli di Martina e Locorotondo, che, pur senza addensarsi nell’abitato di Alberobello, vi danno, sparsi o appaiati su quella terra di color sanguigno e densa e cupa di vigneti, con i loro pinnacoli lisci o squammati, grezzi o imbiancati come cupole di marabutti, la visione d’un paese fiabesco: e quando alla discesa di Fasano si scopre sui poggi e sul piano, contro il fondo cupo e caliginoso dell’Adriatico, la selva dei trulli, sembra che vi si apra un immenso scenario di presepe.
Egnazia ci appare improvvisamente sulla costa tra folate di vento, lungo una via polverosa e incassata fra grosse macerie di massi e di cocciame, sferzata ed erosa dal mare con le sue grosse muraglie, le murate del porticciuolo flagellate dalle onde, il quartiere del Foro seminfossato: tutta una città monumentale in grossi blocchi di pietra nel duro e scabro carparo pugliese, quale non ci si attenderebbe da quegli ornatissimi e forbitissimi vasi, detti di Gnathia, fatti più per profumi e alcove di belle donne, che per queste mura grevi e massicce. Vasi e corredi venivano dalle tombe, depredate le più da scavatori di frodo, complice il mare che, rodendo la costa, scoperchiava e scarniva gli avelli incavati entro la scogliera, sì da fare, direbbe Dante, «tutto il luogo varo». Quando, finite le depredazioni delle necropoli, si pose mano allo scavo dell’abitato con il lodevole proposito di mettere un po’ d’ordine e di chiarezza alle idee, che abbiamo assai confuse su una città messapica nell’Apulia grecizzata e romanizzata, la guerra interruppe nel bel mezzo i lavori e oggi Foro, basilica e colonnati sono rimasti seminterrati tra scoscesi argini di terra. E tutt’intorno sul rilevato dei terrapieni, entro i cortili delle case, sugli spalti della cittadella, tra cocci, calcinacci e pietrame, maturano al sole e al salso del mare i pomodori d’Egnazia, umili e terragni, senza neppure il sostegno d’una cannuccia per quel vento furioso che non ristà. In mezzo alle rovine e ai pomodori, cigola lamentosamente una noria tirata da un ciuco malinconico, e accanto al Foro, una pompa rugginosa, azionata da un motorino scoppiettante, cava l’acqua dal grembo della terra per riversarla nel campo. Ho chiesto un po’ d’acqua al ragazzo sveglio e ardito che governava lo «’ngegno»: l’ho appena saggiata; era d’un forte sapore salmastro. A 1987 anni di distanza, le condizioni di Egnazia erano quali le aveva trovate Orazio nel suo viaggio da Roma a Brindisi con Virgilio e Mecenate (37 a. C.): iratis lymphis exstructa; era la stessa vecchia città costruita sopra vene di acqua salse e amare, come se le Ninfe delle fonti, offese e irate, l’avessero voluta crudelmente punire. Eppure religiosi erano i Gnatini, tanto da vantare come particolare segno del favore degli dei, il miracolo dell’incenso che bruciava da solo sull’ara del tempio; e poiché qualche guida del luogo o qualche paesano di semplice fede, dové mostrare a quella eccezionale brigata di poeti e di politici quello strano prodigio, Orazio ne fece, con l’epicureo Mecenate, le più matte e irriverenti risa. Ma, in compenso dell’acqua salmastra, alcuni villici intenti alla raccolta, forse preoccupati del nostro eccessivo amore per le pietre di Egnatia, vollero propiziarci con una bella manciata di pomodori a cubetti appena tinti di sanguigno, da farne una saporosa e salutare insalata: un dono che Orazio, ai suoi tempi, non poté avere. Molto grati fummo a quei buoni villici; ma non potemmo a meno di pensare, che la sorte degli scavi della messapica Gnathia dipendeva dal dover sacrificare qualche cesta di pomodori all’ancora ignoto nume, dagli archeologi e non senza rammarico, ché a quei pomodori le «linfe irate» di Orazio erano riuscite a dare più buon sapore che colore.
A traverso il Salento
Lecce, novembre 1952
Val la pena di affrontare la stanchezza del viaggio per bearvi, in queste ultime giornate di caldo sole autunnale, delle morbidezze del barocco di Lecce, la più accogliente città apula. Avete lasciato Bari e Brindisi e tutta la serie delle città che mescolano il bianco delle case al colore dell’Adriatico, e vi ritrovate improvvisamente in una città di pietra, senza biancore di case e senza lontano o vicino riflesso di mare, al vertice del triangolo che chiude fra Lecce, Otranto e Gallipoli, l’antica terra dei Messapi e la Grecia salentina. E raggirandovi fra piazze, chiese e palazzi e lasciandovi a mano a mano conquistare dalla curiosità e dal diletto di quelle ornate, intagliate, trinate architetture, fastose e leggiadre, estrose di gusto popolaresco, pur armonicamente contenute nel ritmo delle strutture, non trovate in tutta quella sonora orchestra di pietra, forme e voci di troppo discorde modernità. Perfino a piazza S. Oronzo, che ha subito un magniloquente ampliamento di spazio, il santo eretto sulla colonna romana dell’Appia, sembra autorevolmente imporre un giusto accordo fra le massicce arcate dell’anfiteatro romano seminfossato nel terreno e le eleganti ogive del Sedile di Pietro Mocenigo, le composte forme della Chiesa di S. Maria delle Grazie e i modernissimi portici all’ingiro. Lecce è tra le poche città che ha saputo difendere la sua bellezza, pur essendo al centro della gran raggiera di strade che irradia fra i due mari fino al Capo di Leuca: ampi viali e moderni quartieri alla periferia hanno salvato il cuore della città. A Lecce, in occasione del secondo Congresso Storico Pugliese e del Convegno degli Studi Salentini, ho trovato il fior fiore degli studiosi pugliesi e delle università italiane, studiosi nostrani e stranieri, chiamati a raccolta per onorare la memoria dei grandi Salentini e riattizzare e ravvivare l’interesse per lo studio storico e culturale della regione che è, non è superfluo dire, tra le più ricche e dotate del Mezzogiorno: dai monumenti megalitici e dalle grotte della preistoria, dalle lance basiliane al barocco leccese, dalle iscrizioni messapiche ai dialetti neogreci, e, pur attraverso le più drammatiche vicende di conquiste e d’invasioni, con un substrato tenace di genti e di civiltà, che fanno del Salento una delle terre più fedeli alla sua antica configurazione etnica.
E, a rappresentare il Salento bilingue, c’erano al Convegno i più illustri campioni. C’era Ribezzo di Francavilla Fontana, strenuo e veterano raccoglitore e studioso delle iscrizioni messapiche che sembrava, a sentirlo parlare con quel suo accento mordente, avesse conservato meglio d’ogni altro il tono e l’inflessione dell’antica parlata dei Messapi. S’era iscritto a parlare in tutte le sezioni del Congresso, di storia, di preistoria, di linguistica, e forse per la commozione del sentirsi egli, vecchio e malato, il più schietto rappresentante della gente salentina, non resse alla fatica, e il giorno dopo non l’avemmo più tra noi, caduto come un buon combattente nel cuore della sua terra. E c’era, fra i grecisti, il Rolphs, benemerito studioso dei dialetti neogreci, che a Martano, nella Grecia salentina, dopo un’audizione di cantori popolari, ci comunicò una nuova messe di voci e di espressioni neogreche delle parlate locali. E, fra tanti, mi piacque ascoltare Francesco Gabrieli che, dopo aver ammirato nelle dotte comunicazioni ai Lincei, mi apparve a Lecce, nella vera luce della gentilezza del costume greco salentino, sì da farci rivivere, commemorando Sigismundo Castromediano, la sua giovinezza fra gli ulivi e le pietre della natia Calimera.
Ma, fra gli egregi valentuomini onorati e commemorati, attesi invano che si parlasse del maggiore e più antico, di Ennio poeta, nato a Rudiae, quasi alle porte di Lecce, a Rudiae oggi scomparsa ma che, già in antico, sopraffatta dalla vicina Lupiae (Lecce), aveva, diceva Silio Italico, solo ricordo per il nome del grande suo figlio. Vero è che Ennio, pur vantandosi discendente dell’eroe eponimo della sua terra, il beota re Messapo, abbandonò Rudiae e recatosi a Roma, fu il poeta soldato della prima grande epopea romana, sicché poté dire di sé: «noi siam fatti Romani di un tempo che fummo Rudini». Ma il volontario esodo dei poeti e scrittori del sud continua ancor oggi, e la poesia latina ebbe il suo primo vivido e nazionale impulso proprio dai Greci, semigreci, Messapi e Osci del sud, dal tarantino Livio Andronico, dal messapico Ennio, dal brindisino Pacuvio, dal campano Nevio: sovrano fra tutti Ennio, il pater Ennius come lo chiamò reverentemente Orazio, e come dové considerarlo Virgilio che lo ebbe a modello e ne tolse, ingentilendoli col suo divino tocco, modi e forme del poetare.
Andammo, dunque, con poca brigata, guidati da Mario Bernardini, il dotto e vigile rettore delle antichità leccesi, uscendo da Porta Rusce, a riconoscere il sito dell’antica Rudiae, e dopo aver peragrato per i campi seguendo il rilevato ancora riconoscibile della vecchia cinta messapica della città, aver visto le mura appena emergenti di un anfiteatro indubbiamente più vetusto dell’anfiteatro leccese ed esser discesi in un ipogeo degno di racchiudere il sepolcro di un eroe messapo, convenimmo che se un’esplorazione dev’esser fatta non dovesse tralasciarsi Rudiae, la città di Ennio, il poeta di tre lingue e di tre cuori, com’egli stesso si disse: osco, greco e latino.
Ma, oltre alle dotte e istruttive sedute del Convegno, molto ho appreso correndo per le vie del Salento. Si corre velocemente per il gran tavoliere mollemente ondulato delle vie salentine: una rete stradale che passa tra le più perfette e ricche d’Italia, come mi diceva con legittima compiacenza l’autista Angiolino che, ad onta del nome, aveva la voce imperiosa, rafforzata dalla sicura conoscenza della celebrità dei luoghi, e una mano al volante da sfidare un corridore di circuito.
A Roca Vecchia, innanzi alla costa più nuda e scabra che accolse case e tombe messapiche, ho visto l’Adriatico del più tenero colore verdeazzurro che abbia mai visto, e m’è venuto a mente una mirabile espressione di Ennio: «i cerulei prati del mare».
Traversando la bonifica di Alimni, ho visto come si prepara un terreno petroso per l’aratura ed ho vagliato a dovere la lode che Orazio dava all’aratore apulo (impiger Apulus).
Altrove, bonificare significa prosciugare e colmare; qui, significa spetrare, rompere e togliere la crosta di pietre che copre l’humus al disotto, il buon terreno rossiccio che spiccia sanguigno dall’ossame della terra. E per spetrare, occorre ammucchiare le pietre, farne cumuli e macerie, farne «specchia», con la stessa arte con cui i neolitici di terra d’Otranto costruivano a forma di «specchie» i sepolcri a tumulo per i loro morti, sicché un terreno «specchiato» val quanto un campo spietrato pronto per l’aratura. Fatica dura, anche se a rompere il crostone di pietra si adoperano i trattori, come altrettante macchine poliorcetiche all’assalto d’una fortezza. A Muro Leccese mi han mostrato un menhir spostato dall’asse stradale in un angiporto; l’avessero collocato in una piazza, sarebbe stata la più singolare segnalazione stradale dei nostri tempi; una pietra fitta dell’età preistorica in funzione di regolatore del traffico automobilistico.
Tra gli ulivi vegeti e vetusti e i bassi e fitti vigneti come cespugli, cave di pietra, di quella pietra dolce che parrebbe di poter modellare con le mani, prima che l’aria la rassodi e l’indurisca; e si intende come dinanzi a quella morbidezza plastica, il costruttore e il decoratore si siano abbandonati alla estrosa fantasia ornamentale del barocco leccese. Ma l’uomo ha cominciato assai presto ad aver confidenza con le pietre di questa terra, nelle grotte, nelle tombe, nelle pietre fitte innalzate come obelischi sacri d’una ignota divinità, nelle mura di città che abbracciano sepolcri e abitato.
Partendo da Lecce, incontrammo sulla via di Taranto il fiato umido dello scirocco e le prime nuvole grevi che salivano dallo Ionio, e vedemmo, quasi con stupore, intrisi della prima benefica acqua, mutar colore i campi e quei gran crostoni di pietra che sembravano immutabilmente tinti di sanguigno. Non potei così salutare dalla corriera le mura di Manduria che videro cadere il re Archidamo di Sparta, accorso vanamente in aiuto dei Tarantini contro Messapi e Lucani e sentirono tutto il peso del malumore di Fabio, quando riuscì a riprendere la città ad Annibale. Ma ci riconciliammo tutti, Messapi, Salentini, Greci e Romani laziali sostanziosamente, in fraterna agape, in un popolare triclinio sulla ripa del Mar Piccolo, innanzi a una gran parata di velieri e bragozzi; e, spiritualmente, innanzi alle vetrine delle nuove sale che, al Museo di Taranto, inaugurava il Soprintendente Ciro Drago, un palermitano sodo e di breve loquela, temperata e ammorbidita dall’accento della parlata siciliana, che, dopo aver trascorso qualche anno in austera solitudine con i preellenici di Castelluccia a raccattar cocci fuligginosi e povere collane di grani di terracotta, s’è lasciato corrompere dalle raffinatezze dell’arte tarantina ed ha esposto con elegante modernità di luci, di supporti e di vetrine, diademi, orecchini, collane, monili della più fine oreficeria ellenistica e le statuette fittili femminili di Taranto, degne di rappresentare da sole tutta l’arte delle tanagrée; sembra, innanzi a quelle vetrine, di assistere alle più eleganti mostre di modelli di stagione e vi assicuro che le più belle indossatrici avrebbero da imparare in fatto di grazia e movenze e di femminile regalità d’incesso. Gli orafi di Rue de la Paix e i grandi sarti parigini possono andare ad ispirarsi innanzi ai diademi, ai monili e alle vesti riccamente e sapientemente drappeggiate delle donne tarantine.
-
C. Belli, Prefazione a Passeggiate in Magna Grecia. Rive del Sud, Roma, Edizioni della Cometa 1985, p. 11. ↑
-
Ibidem. ↑
-
A. Maiuri, Passeggiate in Magna Grecia, Napoli, L’Arte tipografica 1963, p. 23. ↑
-
Ivi, p. 185. ↑
-
C. Belli, Taranto, in Passeggiate in Magna Grecia. Costa viola, Roma, Edizioni della Cometa, 1985, pp. 131-157, passim. ↑
-
Quarta di copertina a D. Fernandez, Il viaggiatore amoroso. Viaggio nell’Italia culturale, Trad. a cura di F. Ascari, Milano, Rizzoli 1982. ↑
-
C. Belli, Poeta dell’archeologia, prefazione a Amedeo Maiuri, Il mestiere d’archeologo. Antologia di scritti, Milano, Garzanti-Scheiwiller 1993. ↑
-
Ivi, p. 16. ↑